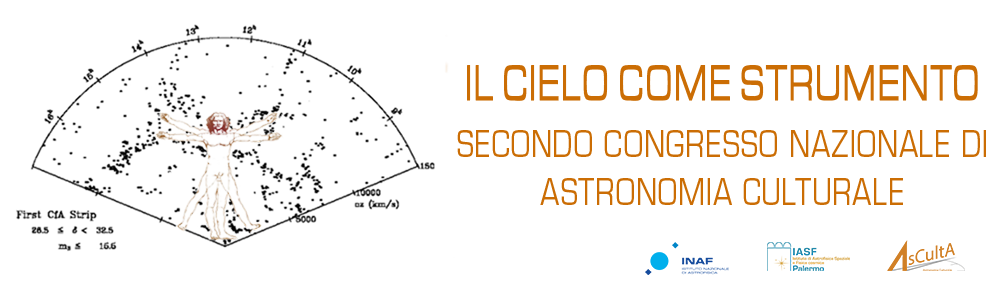Speaker
Description
Galileo e Thomas Harriot inaugurarono l’osservazione della luna nel 1609-1610.
Sono anni in cui l’adozione di protesi ottiche aprì nuovi orizzonti per esplorazioni intellettuali che affiancarono quelle geografiche. I nuovi “paesaggi” suscitarono molteplici interrogativi riguardanti la costituzione dei nuovi oggetti di osservazione. Sotto questo aspetto le problematiche sperimentali e metodologiche dei microscopisti e degli osservatori del cielo presentano forti analogie.
Per gli astronomi il primo scoglio da superare fu l’identificazione di quella che Harriot chiamava “the strange spottedness of the moon”. In proposito, come è noto, è a Galileo che si deve l’ardita abduzione secondo la quale il suolo lunare è del tutto simile a quello terrestre e le ombreggiature osservate denunciano la presenza di crateri e rilievi. Congettura non verificabile all’epoca ma che comportò implicazioni decisive per il futuro delle scienze naturali.
Curiosamente la questione venne affrontata in modo molto originale da un microscopista, Robert Hooke, che nel suo trattato di microscopia, Micrographia, riferisce di speculazioni ed esperimenti di varia natura. Tra questi alcuni semplici ma ingegnosi esperimenti per mettere alla prova diverse ipotesi sulla genesi dei crateri lunari. In questo contributo si ragiona sulla portata delle ricerche di Hooke. Due considerazioni si impongono: innanzitutto si inaugura l’era delle simulazioni (analogiche, in questo caso), segno di un clima di ricerca che da pura attività contemplativa si trasforma in attività che costruisce strumenti e realizza processi artificiali che riproducono fenomeni naturali in condizioni controllate. In secondo luogo i canoni del ragionamento scientifico cambiano radicalmente assumendo come criterio non solo l’analogia strutturale-conformazionale, statica, ma anche quella che potremmo chiamare l’analogia di processo.
Tutto ciò ha implicazioni epistemologiche che toccano la natura della spiegazione scientifica, questione ampiamente dibattuta ma lungi dall’essere esaurita visto che, a tutt’oggi, non esiste una caratterizzazione condivisa che risponda univocamente alla domanda “che cos’è una spiegazione scientifica?”